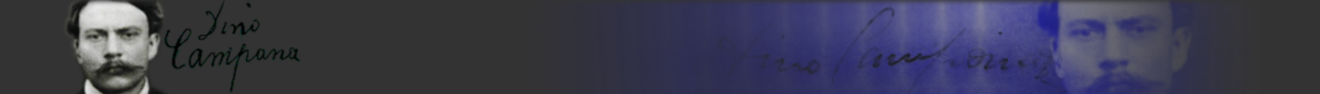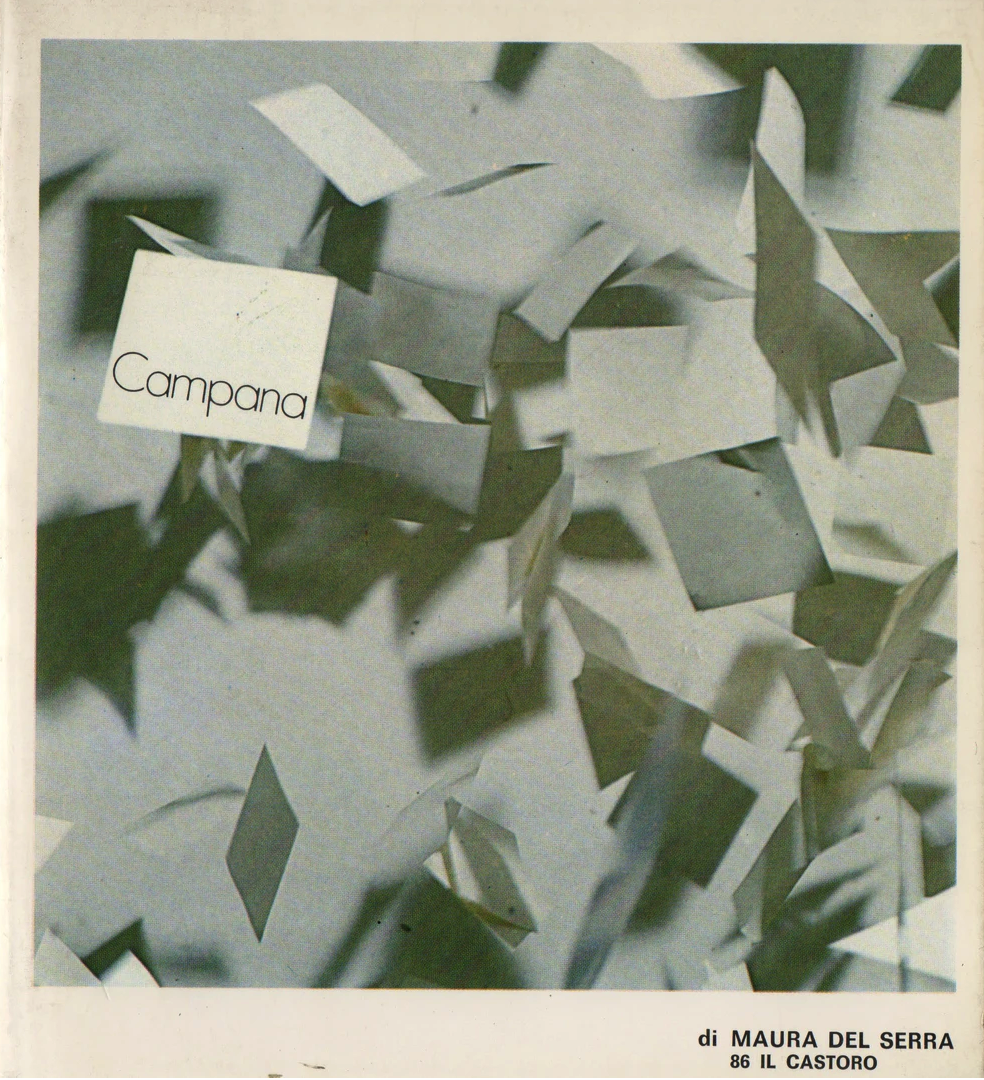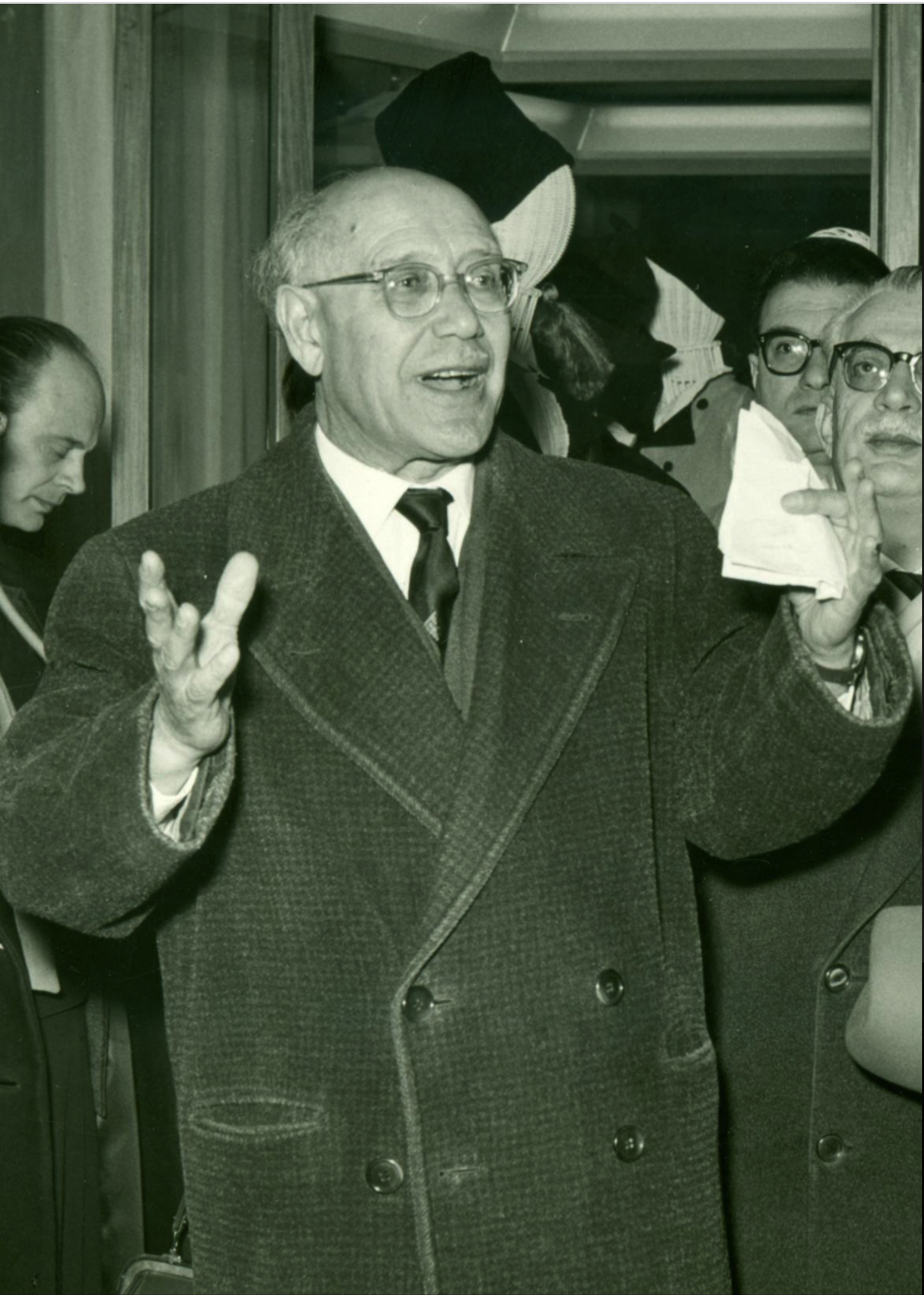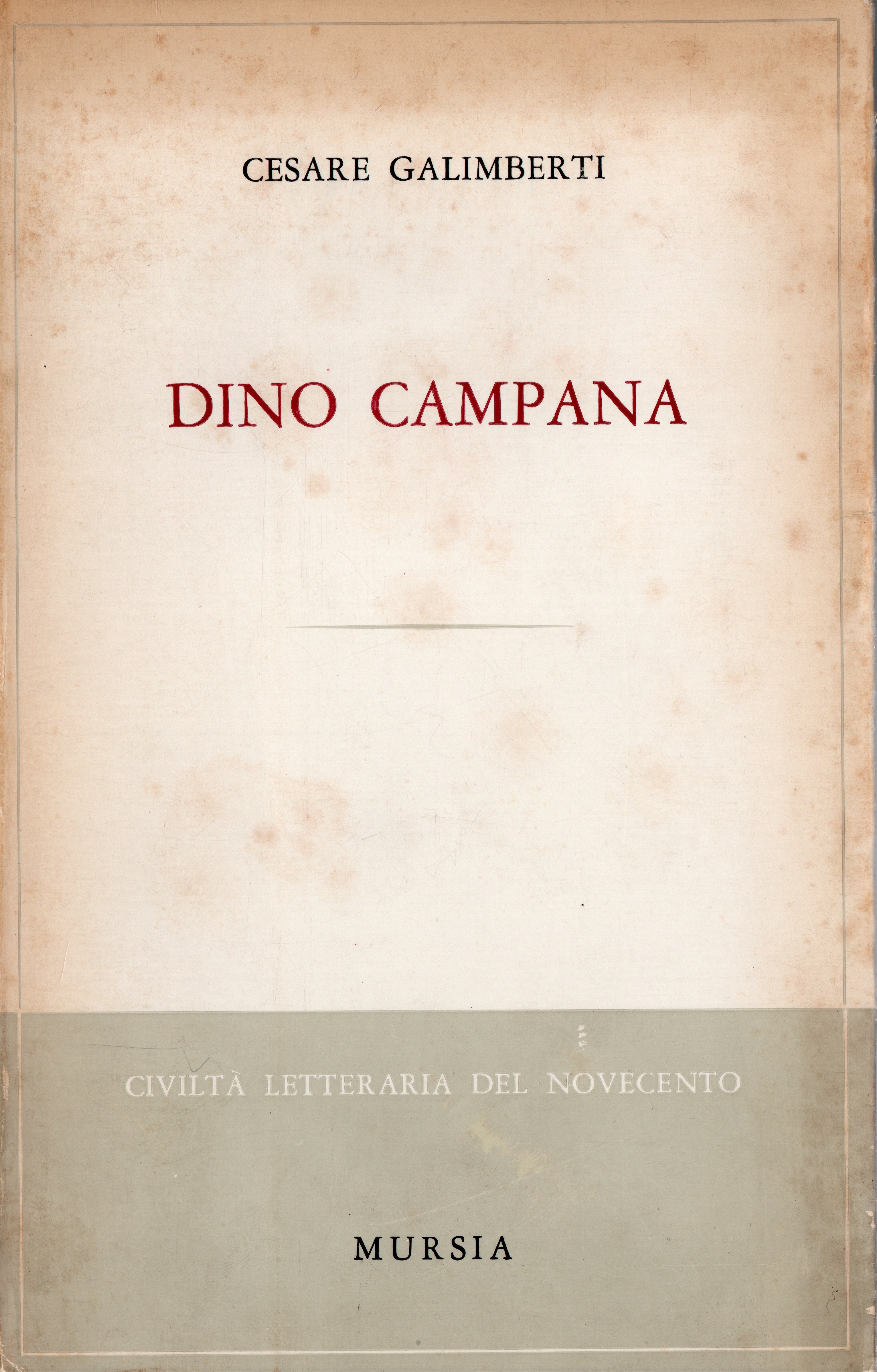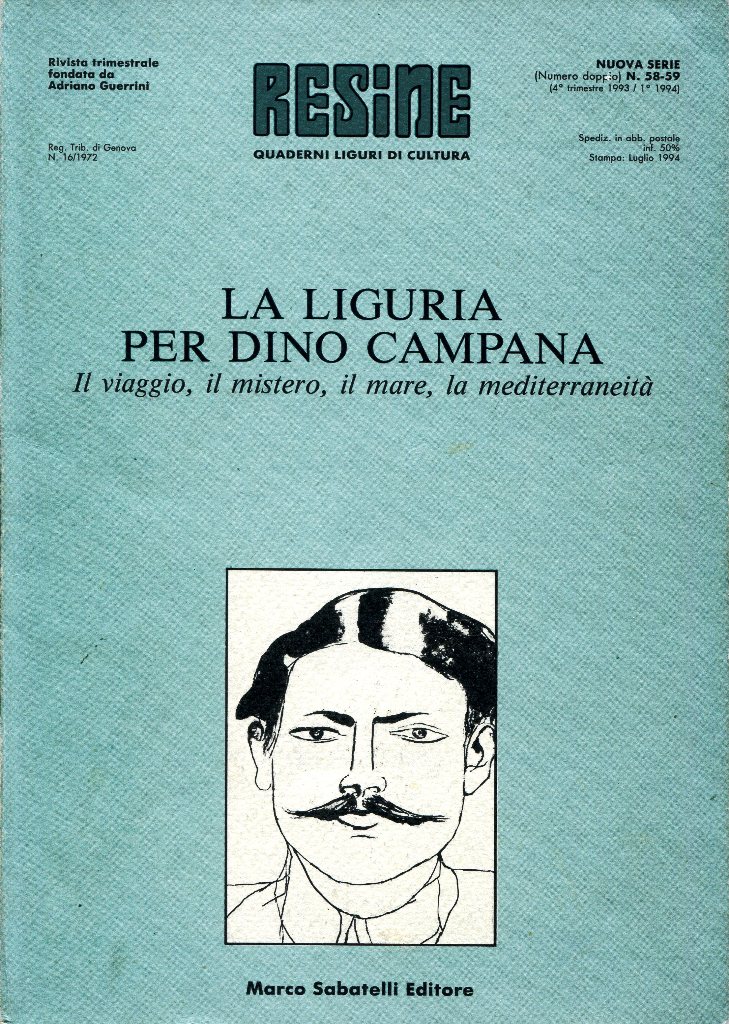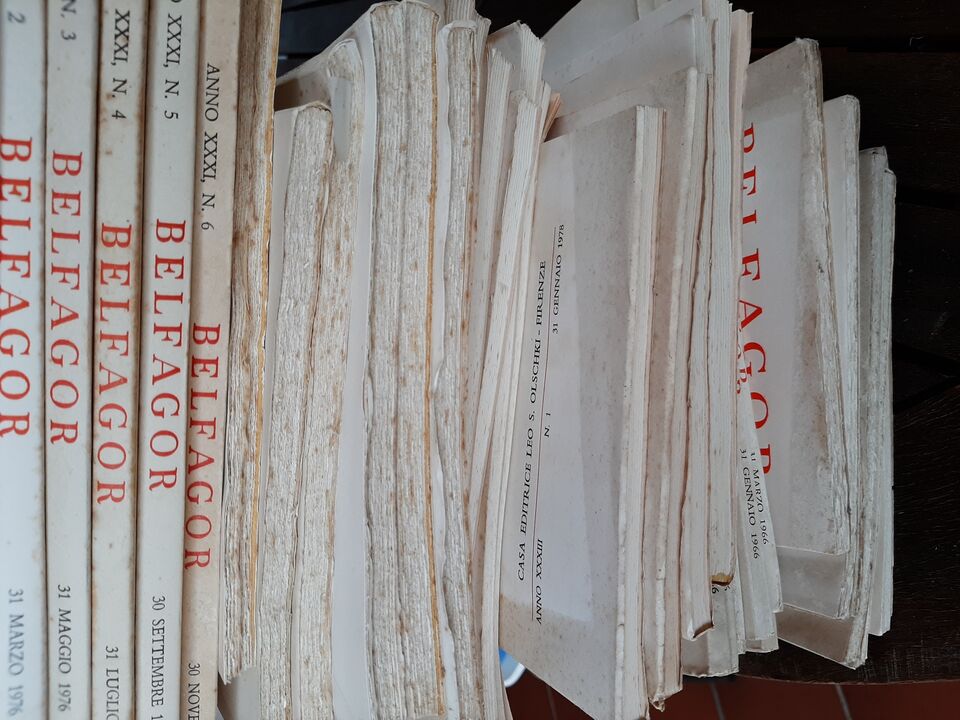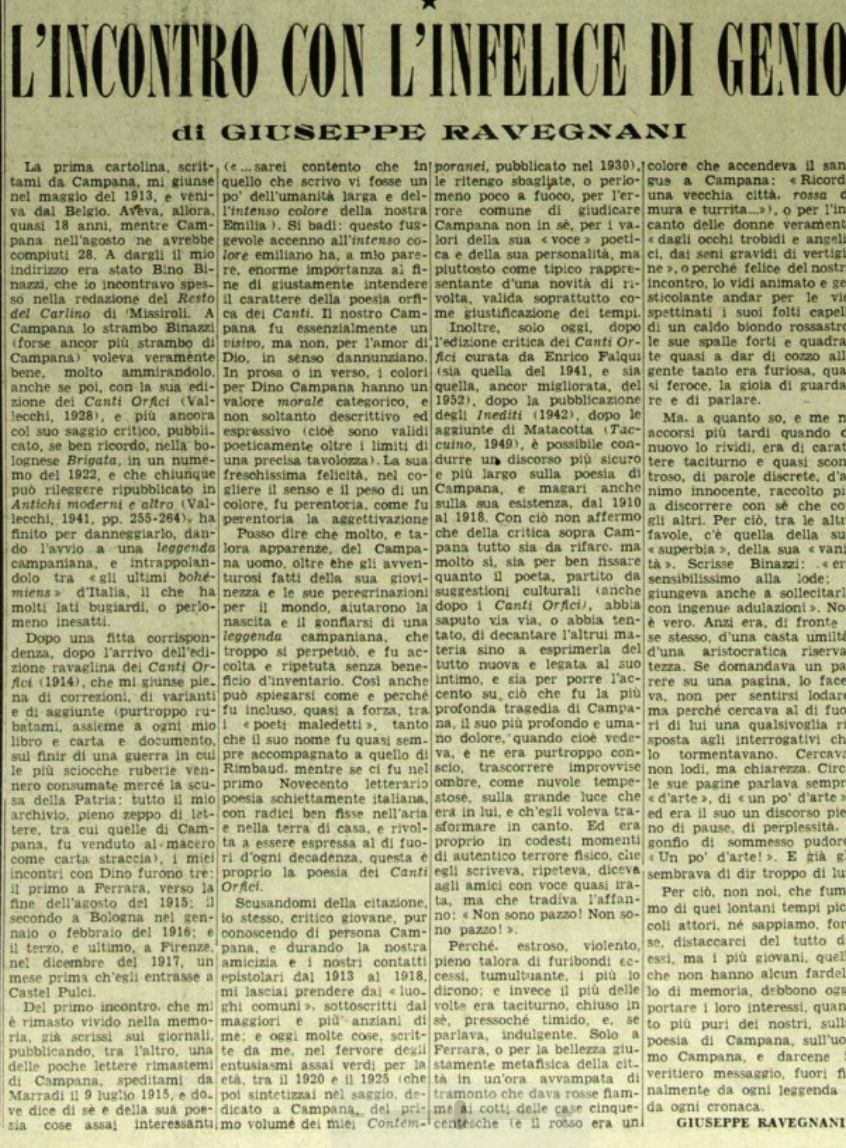«Ora è rinchiuso nel manicomio di Castelpucci». Così terminavano le brevi notizie che Papini e Pancrazi hanno scritto di Dino Campana davanti a una giudiziosa scelta delle sue cose, in quell'antologia degli Scrittori ďoggi, di cui i giovani letterati sogliono dir male fin che non sperano di comparirvi anche loro.
Atti del convegno Firenze 18 - 19 marzo 1973
Seconda Giornata
EVOLUZIONE DEGLI STATI CROMATICO-MUSICALI
Di Maura Del Serra
(Trascrizione di Andreina Mancini)
Il tema di questo intervento costituisce in gran parte l'argomento di uno studio assai più ampio che esamina l'evoluzione della poetica di Campana; perciò non può e non vuole essere, in questa sede, una sorta di improbabile riassunto delle indagini stilistiche e testuali su cui si basano le conclusioni di quello stesso studio, che riguardano il divenire aperto delle immagini lungo l'intero arco temporale dei Canti orfici, che è notoriamente molto composito. Mi sembra dunque che qui possa risultare utile prendere le mosse, come base chiarificatrice, dal periodo centrale della creatività campaniana, quello che va dalla fine del 1910 con La Verna, da questa a Genova (1913 circa) fino agli ultimi frammenti, come Arabesco-Olimpia e L'infanzia nasce.., estremamente ricchi e densi di significati; e in questo itinerario mettere in luce, anche brevemente, il tipo e il significato del viaggio — un termine-guida della poetica di Campana — che le immagini percorrono lungo la loro direttrice costante di evoluzione negli Orfici. La direttrice è quella cromatico-musicale, sinestetica, o meglio analogica; intendendo quest'ultimo aggettivo in un senso dinamico che unisca l'eredità viva dell'analogia musicale del simbolismo europeo con i presagi, presenti nei lirici nuovi ma particolarmente in Campana, dell'analogia essenziale novecentesca, che sboccherà nella poetica dell'ermetismo.
Paolo Toschi
Paolo Toschi: Ricordando.
Il Rimbaud della Romagna
Mario Russo: "Ombrello"
Ricordo di Dino Campana
di Pietro Cimatti
da La Fiera Letteraria - XII - n. 11-17 Marzo1957
Marzo 1932 - marzo 1957: nozze d'argento di Dino Campana con la morte. E nessuna storia lo può ancora (o lo vuole) far capitolo, nessuna storia ancora intende fissarne l'ala che volò in quella mummificante collezione entomologica (farfalle d'oro infilzate allo stilo aguzzo del tempo) che è la storia dei poeti e della poesia.
Si continua a far della cronaca nera: l'occasione Dino Campana non può essere lasciata cadere: troppo poco avventurosa la storia dell'arte nostrana perchè possa permettersi questo lusso: in lui avviene il segreto recupero di secoli di poesia popolati di poeti cortigiani e professori di belle maniere, secoli di penne d'oro e di pergamene preziose, secoli di uomini che fuggivano solo con l'epistolario e qualche passione di donna, di poeti che se ne stavano al caldo.
Dino Campana
di Cesare Galimberti
Mursia Editore, 1967
L'introduzione
Di un poeta come Campana, che agì nella più accesa temperie di fatti e di emozioni e nel segno della poesia come vita, s'impone certo un'interpretazione attenta al rapporto, costante in lui, tra vicende biografiche, esperienze culturali e opera poetica ;1 perché non tanto le singole notizie ma le direttrici della sua esistenza aiutano a rilevare analoghi svolgimenti nel suo mondo poetico, e il giudizio critico può giovarsi di tali raffronti.
Il labirinto mediterraneo negli Orfici
di Maura del Serra
Da "Resine", n. 57-58, luglio 1994
Le rivisitazioni ormai cicliche dei Canti Orfici, dettate ogni volta da un senso che vorrei dire di occasione necessitante, non devono e non possono dimenticare che questo libro è in ogni senso figlio di quei “primi dieci anni del secolo ventesimo” a cui Rebora dedicava i Frammenti Lirici, l'altra memorabile raccolta poetica "sperimentale" del protonovecento: e noi, entrati negli ultimi dieci anni di quello stesso secolo e millennio, non sappiamo ancora, in verità, se abbiamo avuto od avremo un libro di poesia analogo, da levare in parallelo o a contrasto attivo (immaginativamente e spiritualmente attivo) come un pollice catalizzante, rispetto a quell'indice teso con tanta giovanile febbre verso l'oltre, quell'indice che fu la vita-opera di Campana nei suoi fatidici 33 anni di presenza agonica sulla scena del suo tempo. E sappiamo in pectore che, se avremo un tale libro - se aposteriori ci apparirà esistente in questi nostri anni di riluttanti bilanci - sarà in virtù di un soprassalto, di uno scarto accensivo, di uno scatto del montaliano “anello che non tiene” nella complice catena di quel liscio e asettico minimalismo etico che avvolge la nostra epoca post-industriale, post-ideologica, post-umanistica (non vogliamo dire, cedendo alle tentazioni di un millenarismo dimissionario, post-umana, anche se l'occhio ci corre alle prospettive affascinanti e/o terrorizzanti offerte dall'immaginazione computerizzata, dalla cosidetta “realtà virtuale”). Certo il nostro, quello europeo, almeno - è un umanesimo sfiduciato, come ha detto il filosofo spagnolo Fernando Savater, nella capacità di “desiderare bene” cioè in quella facoltà illuminatamente eversiva che comprende tanto le radici dell'utopia quanto quelle del mito e dei grandi progetti individuali e sociali, e che permette all'uomo - in particolare all'artista - di farsi parte attiva, ponte e testimone (mártyr) di quel nuovo mondo nel mondo che ognuno porta con sé come cosciente o smarrito “messaggio dell'imperatore”.
RITRATTI CRITICI DI CONTEMPORANEI
DINO CAMPANA
di Fulvio Longobardi
Da Belfagor , Vol. 2, n. 1, 15 gennaio 1947
pp. 68-74
(Trascrizione di Andreina Mancini e Paolo Pianigiani)
Son mancante, stracciato, ebben guardate
s’è brutto quello che trasparirà;
il cuore dei poeti è ben talvolta
bello già da sé stesso e voi potreste
ben saperlo se solo voi credeste
o aveste un pochettin d'umanità.
Dino Campana
La poesia di Dino Campana ha subìto una strana sorte: i Canti Orfici pubblicati nel 1914 suscitarono appena qualche recensione (De Robertis, Cecchi) sui quotidiani, mentre nelle riviste letterarie l'avvenimento fu quasi ignorato. Vi fu l'articolo di Giovanni Boine sulla «Riviera Ligure» ma di notevole nient'altro. Le parole del Boine delineano con agrodolce franchezza l'ambiente da cui erano usciti e venivano a cadere propizi i Canti Orfici:
C’è in giro per l'arte contemporanea un fermento d'esaltazione, un'aria di novità e di anarchia, un tremore di angoscia che cerca sfogo. Ma c'è anche, e assai più, la preoccupazione di metterlo in mostra e di affermare la propria modernità spregiudicata colla rettorica dell'espressione. La ansiosa modernità di certa gente comincia al di fuori e resta al di fuori. C'è infine gente che finge la libertà essendone nell'intimo sprovvista; e poi che è persuasa dell'ovvia verità che la poesia è dei pazzi più pazzi, si finge dunque pazza e lo fa con scioltezza. Ma questo Campana, per lo stesso impaccio del suo parlare, quello che di elementare e ingenuo la cultura ha lasciato in lui, è, seDio vuole, un pazzo sul serio. Epperciò Te Deum.
L'incontro con l'infelice di genio
oltre la cronaca e oltre la leggenda
di Giuseppe Ravegnani
da
(La Fiera letteraria, ANNO VIII/numero 24 - giugno 1953, pag. 3)
La prima cartolina, scrittami da Campana, mi giunse nel maggio del 1913, e veniva dal Belgio. Avevo, allora, quasi 18 anni, mentre Campana nell'agosto ne avrebbe avuti 28. A dargli iI mio indirizzo era stato Bino Binazzi, che io incontravo spesso nella redazione del Resto del Carlino di Missiroli. A Campana Io strambo Binazzi (forse ancor più strambo di Campana) voleva veramente bene, molto ammirandolo, anche se poi, con la sua edizione del Canti Orfici (Vallecchi,1928) e più ancora suo saggio critico, pubblicato, se ben ricordo, nella bolognese Brigata, in un numero del 1922, e che chiunque può rileggere ripubblicato in Antichi moderni e altro (Vallecchi, 1941, pp. 255-284), ha finito per danneggiarlo, dando l'avvio a una leggenda campaniana, e intrappolandolo tra «gli ultimi bohémiens» d'Italia, il che ha molti lati bugiardi, o perlomeno inesatti.