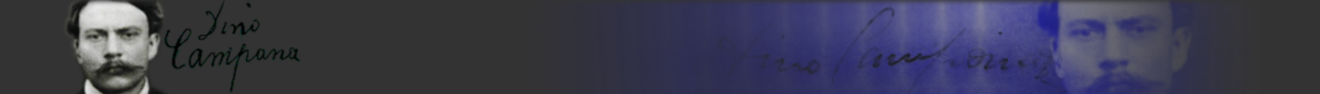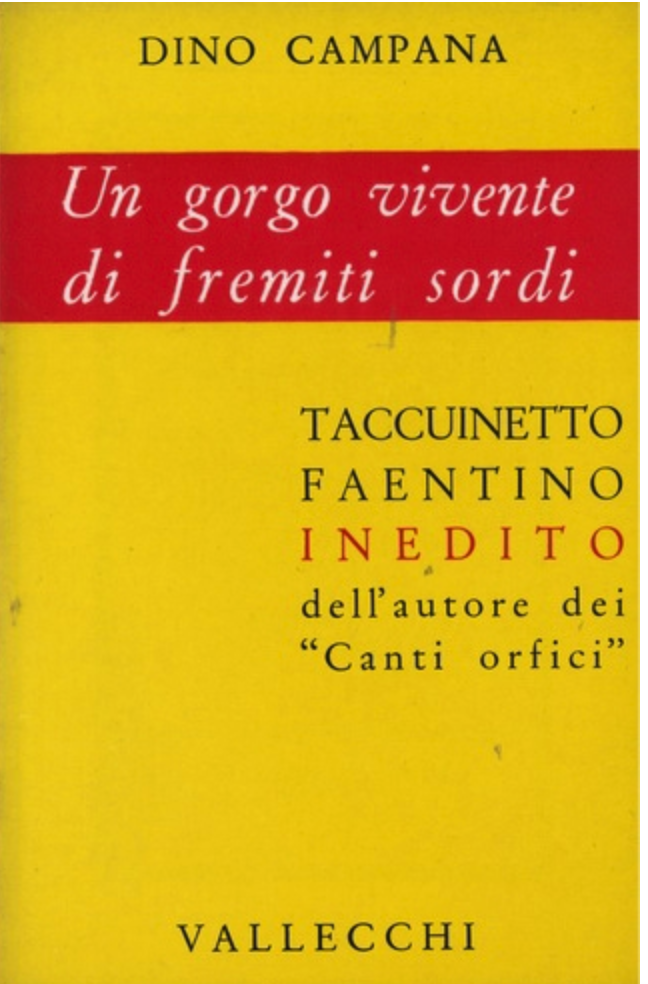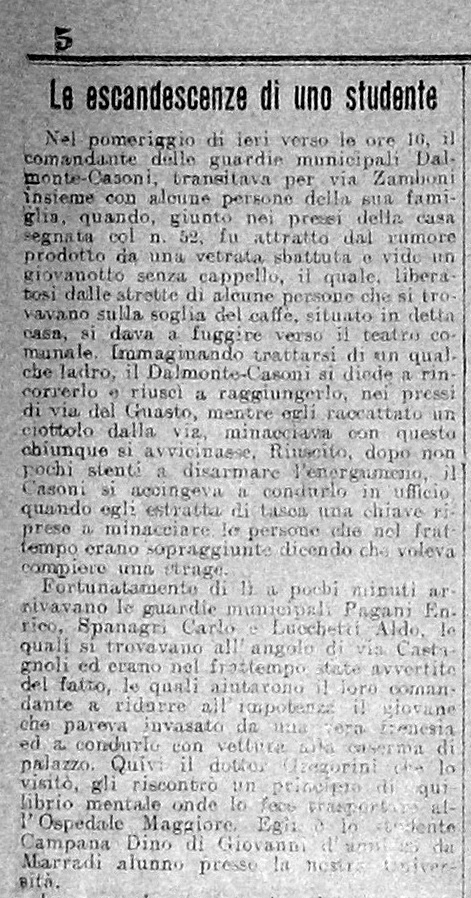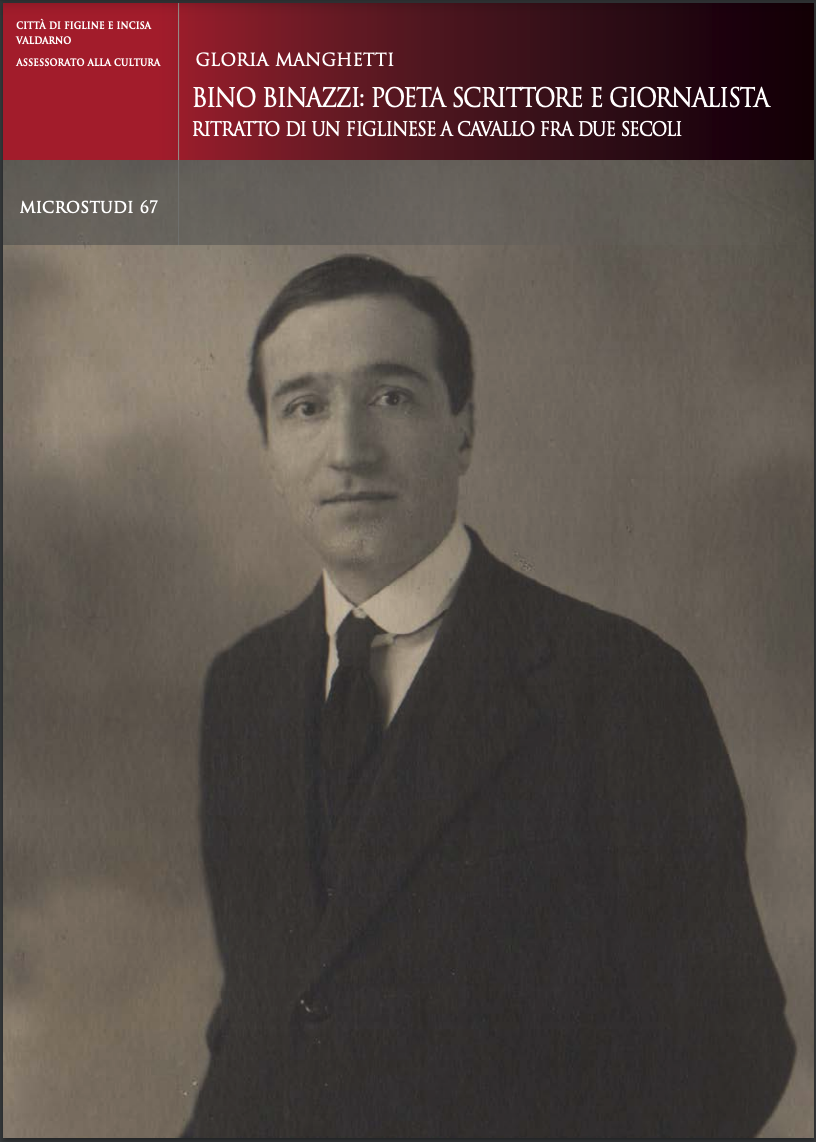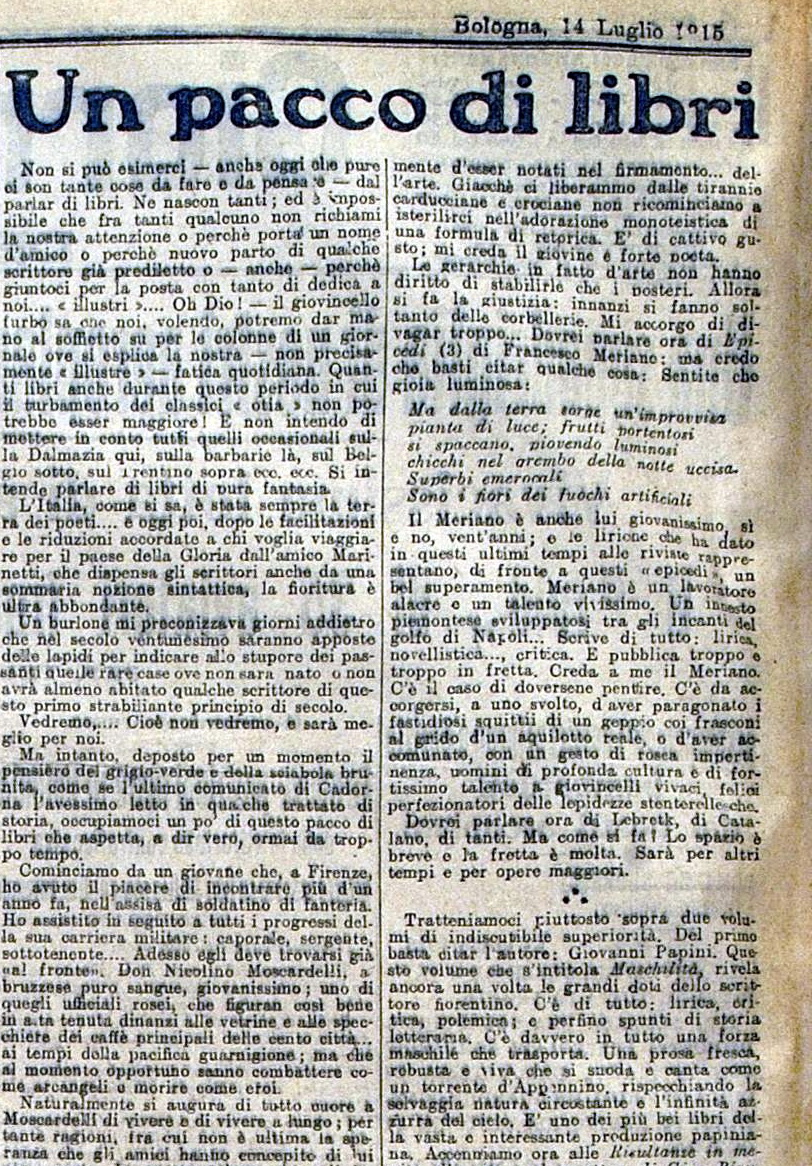Bino Binazzi: Gli ultimi bohêmiens d'ltalia. DINO CAMPANA
da «IL RESTO DEL CARLINO» (Bologna), 12-IV-1922
È balzato fuori dalle mie valigie di nomade un libercolo, che mi è particolarmente caro. Una curiosità bibliografica ormai rara a trovarsi che assomma in se le grazie di una brochure francese, e la ingenuità grossa e casalinga del Sesto Caio Baccelli o del Barbanera.
Questo libro è un gran libro. Forse la più potente e originale raccolta di liriche, che abbia prodotto il ventiduennio di questo secolo di burrasche e di bestialità. L’autore? Dino Campana, nome ancor quasi sconosciutissimo, come ho dovuto dolorosamente accorgermi, facendo degli assaggi in certi angoli di penombra, ove ancora si raduna qualche pavido gruppo di giovani dediti alle lettere.