Giovanni Bonalumi
Un falò per Campana
di Sebastiano Vassalli
da La Repubblica del 27 novembre 1993
Ho conosciuto Giovanni Bonalumi nel 1985, pochi mesi dopo la pubblicazione del mio libro su Dino Campana, La notte della cometa. Bonalumi - svizzero del Canton Ticino - era giunto, negli anni Quaranta, ad amare la poesia di Campana per vie sue, senza essere influenzato dall' ambiente fiorentino e toscano.
La sua tesi di laurea, per cui nel 1946 soggiornò a lungo a Firenze, era stata una delle quattro tesi che avevano mosso l'ira e il sarcasmo del sessantacinquenne Papini sulla rivista L'Ultima:
"Abbiamo avuto notizie sicure", scrisse Papini nel settembre del 1946, "che in questi tempi si son discusse o si stanno preparando per lauree in lettere nelle Università italiane ben quattro tesi sul poeta Dino Campana, morto, come ognun sa, nel manicomio di Castel Pulci nel 1932. (...) Ci sembra che si stia ridicolmente e pericolosamente esagerando il significato storico e il valore artistico dell' infelice poeta di Marradi. Un esame sereno della sua opera dimostra a chiare note ch' egli fu scarsamente originale - s' era nutrito molto di francesi dell' ultimo Ottocento - e che non può essere presentato, se non da fanatici tendenziosi, come autentico e grande poeta".
L' articolo di Papini, intitolato Pazzi in rialzo, conteneva almeno (si fa per dire) un errore, perché una delle tesi di laurea a cui si riferiva - quella, appunto, di Bonalumi - non sarebbe stata discussa in una università italiana, ma nell'università svizzera di Friburgo. Tornando a quel mio primo incontro con Bonalumi: ricordo che già allora lui mi parlò del suo viaggio a Marradi nell'estate del 1946, quando la ferrovia tra Firenze e Faenza era ancora interrotta, e le strade dell' Appennino erano malsicure per via dei banditi.
C' era andato con lo scrittore Nicola Lisi, tecnico agrimensore della Provincia di Firenze, e l'archivista del Comune gli aveva detto le stesse cose che poi si sarebbero sentiti dire per decenni tutti quelli che salivano a Marradi a cercare tracce di Dino Campana: che di lui, in municipio, c'erano soltanto gli atti di nascita e di morte, e che era stato "un vagabondo, un pazzoide, la vergogna della sua famiglia".
Dovevano passare trentanove anni e doveva essere scritto e pubblicato un libro come La notte della cometa per far sì che l'archivio marradese restituisse, nel marzo del 1985, all' improvviso e tutti insieme decine di documenti: dichiarazioni giurate di notabili sulla pazzia di Dino, fogli di via, "module" d'ammissione in manicomio e perfino un verbale dei regi Carabinieri, in cui Dino compie imprese mirabolanti e grottesche.
Quei documenti, che dovevano dimostrare al mondo la mia disinformazione e l'inattendibilità del mio libro, vennero poi pubblicati a tempo di record, nel luglio di quello stesso anno 1985, con il titolo Dino Campana fuorilegge, dalla casa editrice palermitana Novecento; e costituiscono a tutt'oggi l'ultimo capitolo - il capitolo postumo - della storia della persecuzione del matto da parte dei suoi compaesani, dei suoi familiari e di alcuni settori della critica letteraria, da Papini in poi.
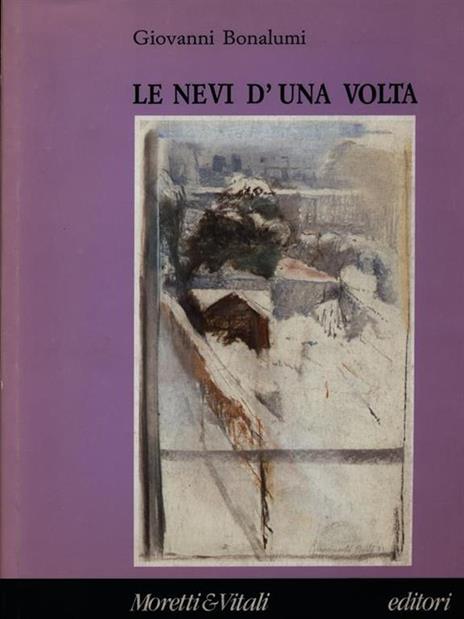
Nel suo bel libro di memorie Le nevi di una volta (Moretti & Vitali, pagg. 106, lire 20.000), Bonalumi ora rievoca, tra l'altro, anche quella lontana visita a una Marradi ancora sconvolta dalla guerra.
"Di lì, come altrove del resto, era passata la guerra. Fresche, come di pochi giorni prima, le tracce. Carcasse di camion, di jeep, abbandonate ai bordi della strada; case ridotte ad ammassi di pietrame; vaste distese di bosco tramutate in un deserto carbonizzato".
E' l'ultimo capitolo del libro: ma confesso di averlo letto per primo. Contiene tre cose memorabili: l'incontro di Bonalumi con l'archivista dell' epoca, il personaggio di Zeffirino e il falò nell'orto dei Campana. L'archivista è "un giovane dall' aria compita" (non sarà stato, per caso, lo stesso archivista del ritrovamento dei documenti nel 1985?); "con ogni verosimiglianza, sincero.
Ma nei riguardi di Campana, al pari dei suoi compaesani, imbottito d' una sfilza di pregiudizi. Sciocco io a non chiedergli, se non altro per esprimergli la mia insoddisfazione, come e quando il Comune si sarebbe deciso ad avviare un' indagine sulle circostanze della sparizione, magari - ipotesi per niente da scartare - dell' occultamento dei documenti serbati a suo tempo in municipio...".
Zeffirino è un antico compagno di scuola di Campana, di professione cantoniere: "un ometto tutto curvato di gambe e di spalle, infagottato in una specie di uniforme dal colore indefinibile", che regala al giovane Bonalumi una copia della prima edizione dei Canti Orfici con dedica autografa dell'autore "A Jole Rivola, 1916".
Bonalumi si chiede: "Chi sarà mai stata? Un'ammiratrice? Un'amica del poeta?"; e il caso vuole che io sia in grado di rispondergli. Jole Rivola era "Jori, occhio di sole"; una giovane donna marradese di cui Dino si era invaghito a modo suo, senza arrivare a dichiararsi in altro modo che leggendole poesie o dedicandole libri; ed era anche la sorella maggiore di quella Nella Rivola, merciaia, che Sergio Zavoli intervisterà negli anni Cinquanta e che gli racconterà di aver assistito alla vendita dei Canti Orfici davanti alle Giubbe Rosse ("Mi sono trovata una sera a Firenze col mio babbo.
Eravamo al Caffè delle Giubbe Rosse, Dino girava tra i tavoli per vendere il suo libro e studiava la gente in faccia; ogni tanto strappava delle pagine"), dimenticandosi del fatto che lei, all'epoca di quella vendita, non poteva avere più di tre anni...
Il falò nell' orto dei Campana, infine, s' era visto dopo la fine della guerra: "In un angolo dell' orto, disse Zeffirino, una domestica della famiglia aveva ammucchiato cestate di roba: quaderni di scuola, per lo più, taccuini, blocchi di fogli; e ne aveva fatto un falò. A lui, Zeffirino, che si trovava a lavorare su un terrapieno, proprio di fronte, erano passati per la testa brutti pensieri...".
Ma nelle Nevi di una volta, a dire il vero, non ci sono solo Campana e i suoi compaesani. Ci sono gli incontri di una vita (Bonalumi, oggi, ha settantatré anni): con il "gran lombardo" Gadda e con la villa brianzola di Gonzalo Pirobutirro; con Montale e Landolfi, Rosai e Parronchi, e con quello stesso Papini di cui Bonalumi dice: "Negli anni della mia gioventù - complice, anche, una certa educazione impartitami - ero giunto a considerarlo una specie di demiurgo, di profeta. Ora (nel 1946), la sua totale sfiducia in una società nuova, più libera, più giusta, il suo radicale pessimismo, me lo facevano distante". C' è una giornata (del 1955) trascorsa ad Alba con Fenoglio, a cui, nel momento di accomiatarsi, Bonalumi promette di tornare a trovarlo. ("Ma già un presentimento mi si era insinuato dentro.
Torpido, inconsulto fin che si vuole; eppure, a suo modo, così struggente. Che non lo avrei mai più rivisto"). E c' è un' altra giornata (del 1979) trascorsa a Econe con il vescovo tradizionalista Lefebvre, che si scaglia contro "il liberalismo cattolico o sedicente cattolico", che ha voluto "sposare la Chiesa e la Rivoluzione", e contro il defunto pontefice Paolo VI: "Il suo liberalismo ha le sue radici in Lutero, Rousseau, Lamennais, Fogazzaro, il cattivo Maritain, Teilhard de Chardin, La Pira, ecc.".
Ma le pagine più belle e toccanti del libro, insieme a quelle su Campana, sono a mio parere le pagine su Robert Walser, un grande scrittore che di Campana avrebbe potuto essere fratello e che come lui morì in manicomio il giorno di Natale del 1956, mentre passeggiava nel parco innevato.
Anche Walser ha la sua Marradi, che si chiama Bienne: "Due anni fa, centenario della sua nascita, a Bienne gli hanno fatto una grande festa. Discorsi commemorativi, letture e interpretazioni di testi, lancio di un premio per un' opera prima. La città, infine, gli ha dedicato una strada. C' è anche una lapide che lo ricorda". Proprio come a Marradi: la strada, la lapide, il premio letterario...
I comportamenti dei normali sono più o meno uguali in ogni parte del mondo; soltanto i matti sono diversi. Dino Campana avrebbe certamente reagito in malo modo all' idea di un premio letterario intitolato al suo nome, in quello stesso paese dov' era stato perseguitato e da cui aveva dovuto fuggire più e più volte ("Qualche traccia del mio sangue è rimasta tra le rocce, lassù").
Di diverso temperamento, invece, Robert Walser si sarebbe lasciato indurre, pur con qualche esitazione, ad ammettere l' utilità e la necessità di un premio intestato a lui; proprio come nel 1929 si era lasciato indurre dalla sorella ad entrare nel manicomio di Waldau, vicino a Berna, limitandosi a chiederle sul portone: "Ma è veramente giusto ciò che stiamo facendo?" (Anni dopo, conversando con il suo amico e tutore Karl Seelig, gli avrebbe confidato: "Il suo silenzio mi bastò. Che altro mi rimaneva se non entrare?"

