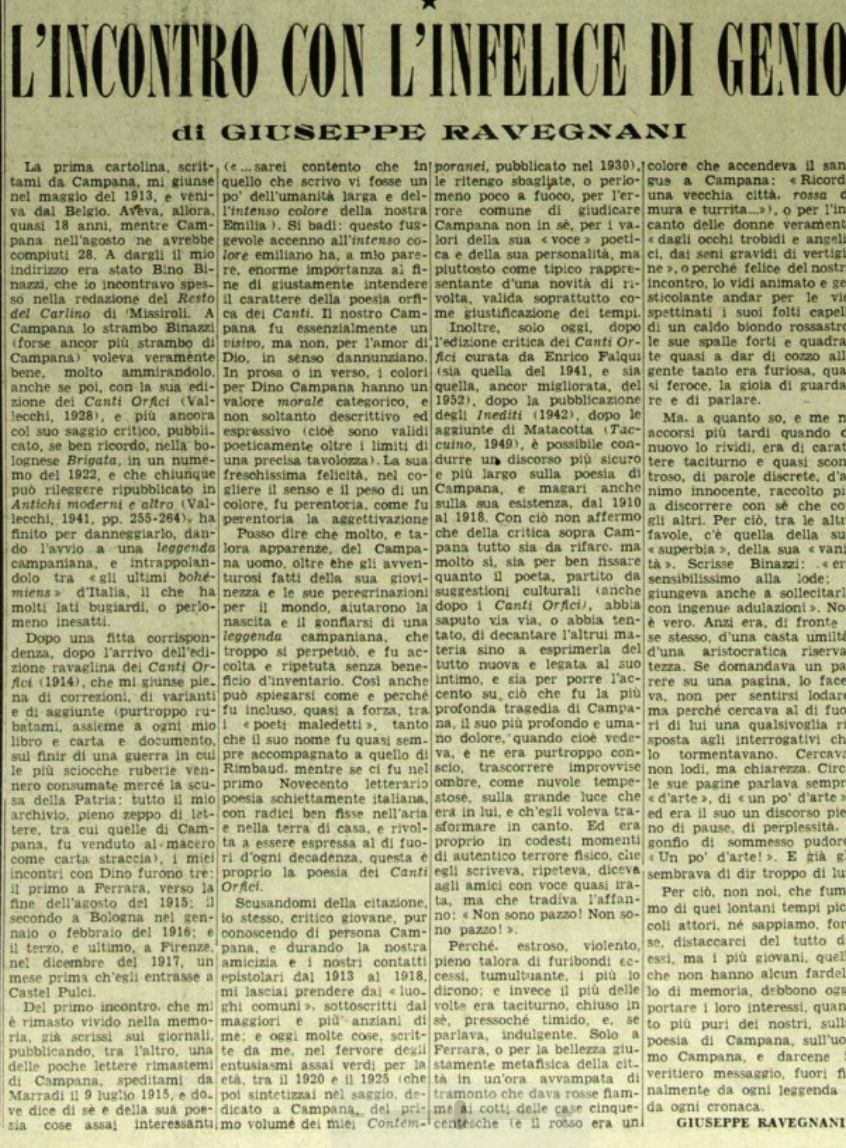L'incontro con l'infelice di genio
oltre la cronaca e oltre la leggenda
di Giuseppe Ravegnani
da
(La Fiera letteraria, ANNO VIII/numero 24 - giugno 1953, pag. 3)
La prima cartolina, scrittami da Campana, mi giunse nel maggio del 1913, e veniva dal Belgio. Avevo, allora, quasi 18 anni, mentre Campana nell'agosto ne avrebbe avuti 28. A dargli iI mio indirizzo era stato Bino Binazzi, che io incontravo spesso nella redazione del Resto del Carlino di Missiroli. A Campana Io strambo Binazzi (forse ancor più strambo di Campana) voleva veramente bene, molto ammirandolo, anche se poi, con la sua edizione del Canti Orfici (Vallecchi,1928) e più ancora suo saggio critico, pubblicato, se ben ricordo, nella bolognese Brigata, in un numero del 1922, e che chiunque può rileggere ripubblicato in Antichi moderni e altro (Vallecchi, 1941, pp. 255-284), ha finito per danneggiarlo, dando l'avvio a una leggenda campaniana, e intrappolandolo tra «gli ultimi bohémiens» d'Italia, il che ha molti lati bugiardi, o perlomeno inesatti.
Dopo una fitta corrispondenza, dopo l'arrivo dell'edizione ravaglina dei Canti Orfici (1914), che mi giunse piena di correzioni, di varianti e di aggiunte (purtroppo rubatami, assieme a ogni mio libro e carta e documento, sul finir dl una guerra in cui le più sciocche ruberie vennero consumate mercé la scusa della Patria: tutto il mio archivio, pieno zeppo dl lettere, tra cui quelle di Campana, fu venduto al macero come carta straccia), i miei incontri con Dino furono tre: il primo a Ferrara, verso la fine dell'agosto del 1915: Il secondo a Bologna nel gennaio o febbraio del 1916: e il terzo, e ultimo, a Firenze, nel dicembre del 1917, un mese prima ch'egli entrasse a Castel Pulci.
Del primo incontro, che mi è rimasto vivido nella memoria, già scrissi sui giornali, pubblicando, tra l'altro, una delle poche lettere rimastemi dl Campana, speditami da Marradi ll 9 luglio 1915, e dove dice di sè e della sua poesia cose assai interessanti (e sarei contento che in quello che scrivo vi fosse un po' dell'umanità larga e dell'intenso colore della nostra Emilia). Si badi: questo fuggevole accenno all'intenso colore emiliano ha, a mio parere, enorme importanza al fine di giustamente intendere il carattere della poesia orfica dei Canti. Il nostro Campana fu essenzialmente un visivo, ma non, per l'amor di Dio, in senso dannunziano. In prosa o in verso, i colori per Dino Campana hanno un valore morale categorico, e non soltanto descrittivo ed espressivo (cioè sono validi poeticamente oltre i limiti di una precisa tavolozza). La sua freschissima felicità nel cogliere il senso e il peso di un colore, fu perentoria, come fu perentoria la aggettivazione.
Passo dire che molto, e talora apparenze, del Campana uomo, oltre che gli avventurosi fatti della sua giovinezza e le sue peregrinazionl per il mondo, aiutarono la nascita e il gonfiarsi di una leggenda campanlana, che troppo si perpetuò, e fu accolta e ripetuta senza beneficio d'inventario. Così anche può spiegarsi come e perchè fu incluso, quasi a forza, tra i «poeti maledetti», tanto che il suo nome fu quasi sempre accompagnato a quello di Rimbaud, mentre se ci fu nel primo Novecento letteraria poesia schiettamente italiana, con radici ben fisse nell'aria e nella terra di casa, e rivolta a essere espressa al di fuori d'ogni decadenza, questa è proprio la poesia dei Canti Orfici.
Scusandomi della citazione, io stesso, critico giovane, pur conoscendo di persona Campana, e durando la nostra amicizia e i nostri contatti epistolari dal 1913 al 1918, mi prendere dai «luoghi comuni» sottoscritti dal maggiori e più anziani dl me; e oggi molte cose, scritte da me, nel fervore degli entusiasmi assai verdi per la età, tra il 1920 e il 1925 (che poi sintetizzai nel saggio, dedicato a Campana, del primo volume dei miei Contemporanei, pubblicato nel 1930), lo ritengo sbagliato, o per lo meno poco a fuoco, per l'errore comune di giudicare Campana non in sè, per i valori della sua «voce» poetica e della sua personalità, ma piuttosto come tipico rappresentante d'una novità di rivolta, valida soprattutto come giustificazione dei tempi.
Inoltre, solo oggi, dopo l'edizione critica dei Canti Orfici curata da Enrico Falqui, (sia quella del 41, e sia quella, ancor migliorata del 52), dopo a pubblicazione degli Inediti (1942), dopo le aggiunte di Matacotta (Taccuino, 1949), è possibile condurre un discorso più sicuro e più largo sulla poesia di Campana, e magari anche sulla sua esistenza, dal 1910 al 1918. Con ciò non affermo che della critica sopra Campana tutto sia da rifare, ma molto sì, sia per ben fissare quanto il poeta, partito da suggestioni culturali anche dopo i Canti Orfici, abbia saputo via via, o abbia tentato, di decantare l'altrui materia sino a esprimerla del tutto nuova e legata al suo intimo, e sia per porre l'accento su ciò che fu la più profonda tragedia di Campana, il suo piu profondo e umano dolore, quando cioè vedeva, e ne era purtroppo conscio, trascorrere improvvise ombre, come nuvole tempestose, sulla grande luce che era in lui, e ch'egli voleva trasformare in canto. Ed era proprio in codesti momenti di autentico terrore fisico, che egli scriveva, ripeteva, diceva agli amici con voce quasi irata, ma che tradiva l'affanno: « Non sono pazzo! Non sono pazzo!»
Perché estroso, violento, pieno talora di furibondi eccessi, tumultuante, i più lo dicono: e invece il più delle volte era taciturno, chiuso in sè, pressochè timido, e, se parlava. Indulgente. Solo a Ferrara, o per la bellezza giustamente metafisica della città in un'ora avvampata di tramonto che dava rosse fiamma ai cotti delle case cinquecentesche (e li rosso era un colore che accendeva il sangue a Campana): «Ricordo una vecchia città rossa di mura e turrita...», o per l'incanto delle donne veramente «dagli occhi torbidi e angelici, da seni gravidi di vertigine», o perchè felice del nostro incontro, lo vidi animato e gesticolante andar per le vie spettinati i suoi folti capelli di un caldo rosso biondastro le sue spalle forti e quadrate quasi a dar di cozzo alla gente, tanto era furiosa, quasi feroce la gioia di guardare e di parlare.
Ma, a quanto so, e me ne accorsi più tardi quando di nuovo lo rividi, era di carattere taciturno e quasi scontroso, di parole discrete, d'animo innocente, raccolto più a discorrere con sè che co gli altri. Per ciò, tra le altre favole, c'è quella della sua «superbia», della sua «vanità». Scrisse Binazzi: «era sensibilissimo alla lode: giungeva anche a sollecitarla con ingenue adulazioni». No è vero. Anzi era d: fronte a se stesso, d'una casta umiltà, d'una aristocratica riservatezza. Se domandava un parere su una pagina, lo feceva, non per sentirsi lodare, ma perchè cercava al di fuori di lui una qualsivoglia risposta agli interrogativi che io tormentavano. Cercava non lodi, ma chiarezza. Circa le sue pagine parlava sempre «d'arte», di «un po' d'arte», ed era il suo un discorso pieno di pause, di perplessità, gonfio di sommesso pudore. «Un po' d'arte!» E già gli sembrava di dir troppo di lui. Per ciò, non noi, che fummo di quei lontani tempi piccoli attori, né sappiamo, forse, distaccarci del tutto da essi, ma i più giovani, quelli che non hanno alcun fardello di memoria, debbono oggi portare i loro interessi, quanto più puri del nostri, sulla poesia di Campana, sull'uomo Campana, e darcene il veritiero messaggio, fuori finalmente da ogni leggenda e da ogni cronaca.
GIUSEPPE RAVEGNANI