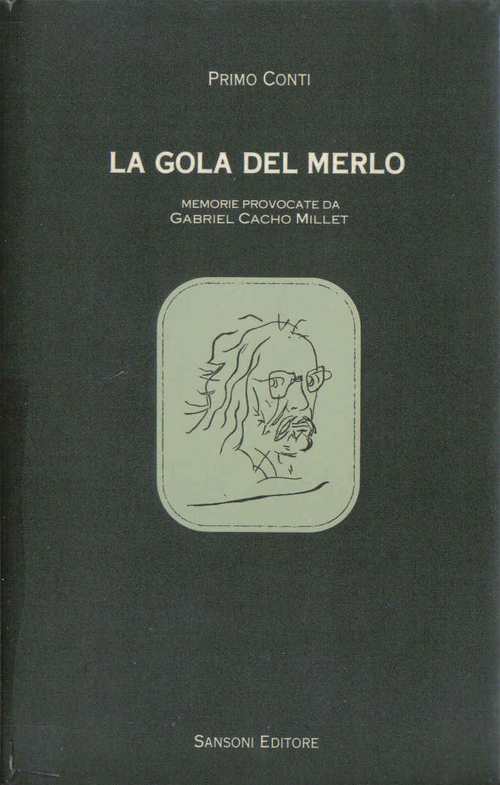Primo Conti: Campana, ultimo discorso
Intervista a Primo Conti su Dino Campana, inclusa con alcune varianti nel volume
"Primo Conti, La Gola del merlo, Memorie provocate da G. Cacho Millet, Sansoni, Firenze 1983".
Pubblicato anche in: "Dino Campana Fuorilegge", Edizioni Novecento, 1985
a cura di Gabriel Cacho Millet
PRIMO CONTI
- Ricordo Campana come una specie di spirito vagante sulla terra, una specie d'arcangelo che disse quello che doveva dire e poi sparì. Sembrava uno di quei girovaghi nordici, fisicamente splendido, scalzo, col bastone sulla spalla e appeso al bastone un sacchetto di tela dove teneva i libri, le camice e un paio di scarpe che spesso si infilava per la strada.
Qualche volta è venuto di sorpresa a trovarmi nello studio perché amava il senso popolaresco dei miei collages e non è a caso che Cesare Vivaldi e Luciano De Maria abbiano rilevato nei miei dipinti e nelle mie poesie di allora un segreto legame coi Canti Orfici.
Ricordo di aver girato per Firenze con lui e che mi imbarazzava tenermelo accanto perché lo guardavano tutti. E poi non era uomo da impegnarci la giornata. Con quel suo passo lento e cadenzato a un certo punto svaniva. Ti voltavi e non c'era più; lo avevi a fianco e poi a un bel momento, eri solo. Era andato via, non si sa come, in silenzio.
Campana, non diceva mai «buongiorno» né «arrivederci». La frequentazione di Campana era affidata al vento, proprio come il profumo dei fiori che a un certo momento lo senti e poi non c'è più. Era un dono che ti arrivava all'improvviso, lo incontravi quando meno lo pensavi. Con Campana non credo che si potesse nemmeno immaginare un appuntamento. Potevi prenderne, se volevi, però era più facile trovarlo a caso sulla strada.
GABRIEL CACHO MILLET
- Dove lo hai conosciuto?
P. C.
- Lo trovai allo studio di Giovanni Costetti come avrei potuto trovarlo in qualunque altro posto, perché Campana vagava da un luogo all'altro senza fare alcuna scelta fra la gente che si trovava intorno.
G. C. M.
- Leggo nel tuo Diario inedito:
«Marradi 2 gennaio 1917. Sul tavolino i due nuovi acquisti : Simultaneità - Chimismi Lirici di Soffici e Canti Orfici di Campana, frutto delle dieci lire del mio "ceppo", mi riempiono l'anima di fiamme...».
P. C.
- Li acquistai, infatti, coi soldi del «ceppo» ; una festa che capitava ai primi di gennaio. Erano 10 lire che seguitavo a ricevere ogni anno anche quando non ero più bambino. Avevo allora, 16 anni. Quello che oggi ricordo è che i Canti Orfici li comprai direttamente da Campana, perché a parte tutto, quel piccolo libretto dalla copertina solare, non si trovava da nessuna parte. Lo vendeva lui stesso agli amici, tirandolo fuori dal sacchetto che teneva infilato al suo bastone.
G.C.M.
- Senti un po', Primo. Verso la fine del '15 Campana consigliato probabilmente da un tuo compagno di lotta, diciamo così, de «L'Italia Futurista», il siciliano Antonio Bruno del quale dobbiamo ancora parlare...
P. C.
- Era una specie di Leopardi in formato ridotto del nostro gruppo, e non soltanto perché gobbo...!
G. C. M.
- Ecco, dicevo, che forse fu Bruno a consigliare Campana di inviare i Canti Orfici al suo illustre conterraneo Giovanni Verga il quale rispose poi laconicamente «ringraziando e congratulandosi». Queste cose mi sono venute in mente leggendo ne «L'Italia Futurista» del 18 novembre 1917, una rassegna di critiche al volumetto di Bruno Fuochi di Bengala, dove ai giudizi di un Verga di una Ada Negri, e di alcuni giovani del secondo futurismo fiorentino, te incluso, si univa quello di Campana. Tu sai che Campana accusava di vuotaggine il primo futurismo. Diceva che i versi dei poeti futuristi erano «falsi» e «senza armonia» e se è vero quello che si dice, vendette a Marinetti soltanto la copertina dei Canti Orfici perché pensava che non avrebbe capito il resto. Cosa ricordi di questo giudizio di Campana su Bruno ripreso ne «L'Italia Futurista» ?
P. C.
- Non ho memoria di questo giudizio di Campana eppure dovrei ricordarmelo perché il giornale lo stavo facendo già io... Cosa diceva Campana dei Fuochi di Bengala?
G. C. M.
- «Il vostro libro mi piace perché v'è quella saldezza della tempra aristocratica che è necessaria per salvare il carattere della letteratura». Lo ricordi ora?
P. C.
- No. E pensa che devo essere stato proprio io a correggere le bozze di quel numero.
G. C. M.
- E' un peccato perché io penso sia indicativo di un atteggiamento diverso di Campana verso quel futurismo che voi stavate facendo. Pensa che ebbe contatti epistolari con Franchi fino all'ultimo. C'è una cartolina, ormai appena leggibile dove lo ringrazia per un trafiletto apparso sulla «Humanitas» di Bari, e gli dice:
«quanto all'ingranaggio, Dio ci salvi che ci protesse finora. Il povero selvaggio mostra ancora dell'orgoglio... Perdonaglielo... e credimi nei tuoi amici...».
Era amico-nemico del tuo carissimo Tommei. Era in contatto con Rosai, che di lui ha scritto una limpida testimonianza su «Literatura» nel '53 nella quale parla del suo ritorno dalla guerra e del dolore provato al non trovare più Campana per le strade di Firenze. Poi c'è Remo Chiti che veniva dalla «Difesa dell'Arte » un giornale dove Campana, «uomo ancora inedito», cercò d'offrire la sua collaborazione «per far passare un po' di giovine sangue nelle vene di questa, vecchia Italia» e dove Chiti scrisse sul «dolce e severo» Segantini, pittore amatissimo da Campana.
E poi ancora c'è Bruno Corra il quale gli donò appena uscito in «omaggio futurista» il suo libro Con mani di vetro. E possibile che tu abbia visto Campana bazzicare il Caffè ufficiale della «Pattuglia Azzurra», il «Caffè Moderno», forse con uno di loro, o con Antonio Bruno... Cerca di ricordare, Primo.
P. C.
- Non ricordo di aver visto Campana al Caffè Moderno, che era il caffè dove noi si lavorava e si scrivevano gli articoli per il giornale. Ricordo invece di averlo visto una sera alla Birreria Pilsen, che era un piccolo bar prevalentemente dedicato alla birra tedesca e situato in un angolo della piazza Strozzi. Qualche volta, alcuni di noi si trovavano in questo bar. I più assidui erano Nerino Nannetti, il fratello di Settimelli che si firmava Spina, e Ghiri. Non ho memoria invece di aver visto Corra, Rosai o Bruno al Pilsen. Campana ci capitò una sera. Veniva dalle campagne di Lastra a Signa, a piedi, e nel moticcio delle sue scarpe e era, infatti, qualche filo d'erba che faceva uno strano effetto in quel riflesso di specchi cittadini. Ci salutò col suo consueto saluto che somigliava molto a una cartolina spedita da lontano, e si accomodò al nostro tavolo con l'aria di volersi nascondere all'ombra del clamore da qualcuno che pareva lo inseguisse. Poi all'improvviso, ma con grande calma, prese il nostro vassoio dal tavolino, lo posò sopra una seggiola vicina, montò sul tavolino e cominciò a parlare con un tono insolitamente tribunizio: «Guardate che qui siamo in piena guerra, questa guerra spaventosa, tragica... Sappiate che il colpevole della guerra sono io, che la causa di questa guerra è il mio amore con Sibilla Aleramo...».
Le parole gli uscivano come dalla finestra di una prigione, in disordine, e ora mi è difficile ricordarle con esattezza. Poi ci guardò quasi trattenendo il suo tormento. Qualcuno di noi, istintivamente, tirò indietro la sedia. Da principio si pensò a uno scherzo, ma poi si capì che lui faceva sul serio. Ricordo che Nerino Nennetti uscì di soppiatto, non so se per telefonare a qualcuno o per avvertire un ospedale. Ma Campana, conclusa quella sua dichiarazione così netta e piena di angoscia, si rasserenò, scese dal tavolino, rimise il vassoio al suo posto, e tornò a sedersi come se nulla fosse stato.
Non ricordo se andò subito via. Restò comunque in tutti noi la sensazione che qualcosa di molto grave era successa nello spirito del nostro amico, il primo avviso, credo, di un suo definitivo scomparire dalla nostra vita: di quella che lui chiamò poi la sua «confusione di spirito». E' strano che nel corso della mia cordiale amicizia con Sibilla Aleramo, non si sia mai parlato di lui.
G. C. M.
- Fatta eccezione per Agnoletti che andò a trovare Campana al Manicomio di Castel Pulci per dargli coraggio di riprendere le sue attività letterarie (malgrado che i medici dell'Istituto gli avessero detto che il malato «non era in condizioni di ricevere visite di chicchesia» e che in tutto quello che Campana stava allora scrivendo «non c'era ombra di senno»), tu sei forse l'unico dell'ambiente letterario e artistico fiorentino che lo ha seguito da vicino nell'ultime «stazioni» di quel suo Calvario.
P. C.
- Sì, me ne interessai come potevo, e ne informai Raimondi.
G. C. M.
- Ho trovato infatti nel tuo archivio tre delle cartoline che lui ti scrisse a questo proposito. Tutte e tre sono dell'aprile 1918. Nella prima, in data 5, ti dice:
«Io devo chiederti un favore: di recarti in via Jacopo Nardi 15, dalla signora di E. Cecchi per chiedergli notizie di Dina Campana, il quale fu internato un mese o due fa al Manicomio di San Salvi: vorremmo sapere se è uscito e dove si trova presentemente. Vacci a nome mio e di R. Bacchelli...»
Nella seconda, che è del giorno 12, Raimondi ti scrive:
«Ti ringrazio molto di esserti interessato per Campana, ma ti sarò ancor più grato se potrai mandarmi altre notizie: consiglia a quel tuo conoscente d'assicurarsi se l'amico si trova ancora a San Salvi, se è stato trasferito in un altro ospedale o se è stato messo in libertà..."
Nell'ultima, del 17, molto laconica, Raimondi ti ringrazia:
«Caro amico, grazie della premura che hai per me; e grazie per le notizie di Campana che purtroppo non sono troppo buone: era da prevedere...! »
P. C.
- Più tardi, dopo il 1920, perché lo scultore Boncinelli già era entrato a far compagnia a Campana nel manicomio, ho conosciuto al «Caffè Moderno» un dottore giovane, sardo di nascita, del quale non ricordo il nome, che correva dal manicomio fiorentino di San Salvi a quello di Castel Pulci, in qualità di vice-direttore. Lui mi parlò di Campana, ed io gli raccontai di quell'ultima sera d'inverno al «Pilsen» quando lo vidi ammattire.
G. C. M.
- Su un foglio volante che ho trovato nei tuoi cassetti, riporti il dialogo che avesti con quel medico al caffè. Quando tu gli stavi raccontando l'episodio della «Birreria Pilsen», lui interloquì:
«Io invece l'ho rivisto ieri, e mi è apparso calmo come un bambino malato. Tutta la sua forza gli resta serrata dentro, come per un comando superiore al quale Campana ubbidisce. Campana è un pazzo dolce e buono, pieno di ritegno e di timidezza.»
Poi gli chiedesti di Boncinelli e lui ti rispose così:
«Si tratta del caso opposto, diametralmente opposto; Boncinelli è un pazzo che non conosce riposo!»
E poi, a mo' di chiusa, c'è questa tua nota nostalgica:
«Ripeto a memoria qualche poesia dei Canti Orfici, e guardo l'affocata piazza estiva, piena di gente che corre, e non si sa dove arriverà.»
P. C.
- Sapevo a memoria tante poesie di Campana. C'era un periodo della mia vita fiorentina dominato dalla presenza di Campana, anche se lui non si vedeva mai, ed era raro incontrarlo. ma, faceva Campana, come si dice che fa caldo o fa freddo. In quel clima io mi trovai a scoprire non il Campana «pazzo» o, come diceva Papini «ingombrante», ma il Campana plebeo.
Micacchi, in un articolo pubblicato su «L'Unità» nell'occasione della mia mostra romana al Palazzo dell'Esposizioni, parlò di una scoperta della plebe in alcune mie opere giovanili. Quella plebe non è la classe dei poveri né il popolino di Rosai. E quella gente truce, feccia e ultimo strato della società, rigurgito di bassi fondi, che non ha coscienza politica come il proletario che vuoi progredire e cammina. Il plebeo non progredisce, è la forma pura e immobile dell'essere assolutamente diseredato. Ebbene, in Campana si glorifica questa forma pura, questa voce che, a notte fonda «quando tante cose sono state spazzate» sembra dare un volto alle tenebre.
E può sembrare strano che io, venuto dalla piccola borghesia, mi sentissi proiettato verso questa umanità greggia e non addomesticabile. E che riuscissi a trovare in essa il fondo di me stesso, il germe di quella «metafisica da osteria» dove anche Campana, angelo plebeo, poteva ritrovarsi a cantare:
Per le rotte
De la notte
Il mio passo
Batte botte.
In Campana c'è quell'elemento agreste, quasi tattile, dei cespugli, delle rocce; qualche cosa di cosmico che acquista un senso di magia e che non si risolve mai nel pittoresco: fissa un orizzonte che è dell'anima, e non un orizzonte di rapporti spaziali. Termine che è oltre la visione delle cose [...].
E a proposito: sai dirmi in che anno morì Campana?
G. C. M.
- Nel 1932, perché?
P. C.
- Ecco, nel decennale della morte di Campana, Giuseppe Bottai venne a Firenze per presiedere alla cerimonia della sua tumulazione. I Bargellini marito e moglie, avevano ritrovato le spoglie del poeta al cimitero di San Colombano e mi dissero che quando il becchino rintracciò il teschio si accorse che rideva con ancora tutti i suoi denti.
Rivedo ora come in una nebbia gelata. Gatto e Montale sollevare la piccola cassetta coi resti di Campana e deporla sull'altare per l'inumazione. E poi Rosai e Carlo Bo, che aveva ancora un faccia da bambino, ornare la sua tomba con una semplice corona d'alloro: la più semplice che si potesse trovare.
Papini era in piedi, accanto a Bottai. Pregava.
G. C. M.
- Meglio tardi che mai!