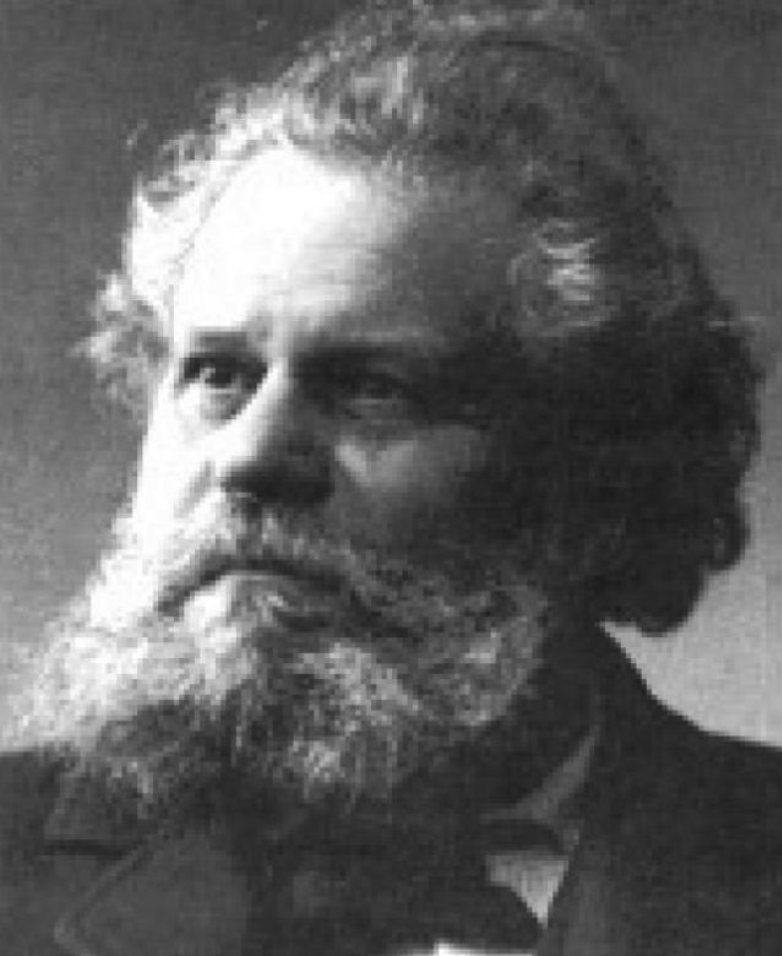Giosuè Carducci
Walter Mauro: Il rapporto fra Giosuè Carducci e Dino Campana
Dal primo numero del 2007 della rivista, "Pagine della Dante", della Società Dante Alighieri
Nella notte del 16 febbraio del 1907, esattamente cento anni fa, moriva Giosué Carducci, a settantadue anni, e con lui scompariva la prima figura rappresentativa di quel secondo Ottocento che ha rappresentato per la poesia italiana l’avvio di un dettato poetico nuovo e diverso, dopo la grande triade del preromanticismo e dell’idealismo che con Foscolo, Manzoni e Leopardi aveva rappresentato un momento di intensa e incomparabile tensione poetica, i cui riflessi, del resto, non mancheranno di illuminare anche la parola e il lavoro letterario della seconda parte del secolo, fino al primo Ottocento. Due giorni dopo quel 16 di febbraio, si svolsero i funerali: dietro il feretro, da Mura Mazzini fino al cimitero della Certosa, a Bologna, c’erano autorità politiche, Filippo Turati fra gli altri, Alfredo Oriani, e soprattutto, come presenze non soltanto simboliche, Giovanni Pascoli dalla pace di Barga, e Gabriele D’Annunzio.
Si ricomponeva quella triade che un critico di grande valore del tempo, Enrico Thovez, definì «Il pastore, il gregge e la zampogna», indicando in questa fortunata definizione il senso di guida e di derivanza che la poesia carducciana, soprattutto quella dell’ultimo periodo legato alla raccolta Rime e ritmi, aveva significato nella vicenda della poesia italiana del secondo Ottocento, o meglio della transizione dall’ideaiismo romantico al decadentismo. Un legame con la nuova poesia nascente certamente controverso, che ha diviso la critica in due schiere altrettanto compatte e combattive: infatti se alcuni richiamano, con documentazione precisa e attenta, la lezione parnassiana e soprattutto di Charles Baudelaire, altri, per esempio il De Robertis, tendono a individuare come nel carduccianesimo di Dino Campana, che è il poeta che abbiamo scelto come termine di riferimento fra due poeti che pur presentano non poche diversificazioni, persistano spiriti e forme che tendono a evidenziare una ispirazione diversa e più sana e più pacata: «Meno spirito decadente - scrive De Robertis – e meno sensibilità atroce, ma un gusto di cose vive e rozze, in un genere dominato dalla pienezza.
Su questa base Dino Campana ha lavorato a scoprire il suo canto, che si è fatto di certe armonie semplici, di ripetizioni e riprese di parole, di assonanze, di rime, anche se manca il verso, e di un periodare che si direbbe eloquente, ma la determinazione suggerisce un’idea abusata e usuale. Certo che bisogna prima accettare queste particolarità non peregrine, per sentirsi dentro un’ansia commossa, con battiti di sillabe fatte canore. Col tempo viene a stabilirsi intorno come un’atmosfera di colori e di odori, e ogni parola o linea si giustifica. Lasciamo stare certa sensibilità esasperata che la moda ha portato, e i tratti pittorici risaltanti, e le luci carnose; qui quel che c’è d’autentico è la ricchezza di intonazioni musicali, che a un punto si dilatano e si smorzano, una continua efflorescenza di note larghe a cui manca per ora una forza di coesione, e una certa ascesa sopra nodi melodici successivi.
Tutto il resto, pur bello, si può trovare altrove: immagini, rapporti strani, associazioni, richiami imprevisti, colori vivi».I due giudizi critici non sembrano poi tanto contraddittori: in realtà, essi scorrono paralleli e da una loro disamina potrebbero scaturire interessanti strumenti di studio, specialmente nell’ambito di quell’«avvenire critico», che proprio il De Robertis aveva preconizzato al Campana, fin dai tempi del Leonardo, ma anche, d’altro canto, per una puntuale identificazione di elementi decadentistici nella poesia del Carducci.In un suo saggio sul poeta maremmano, apparso nel numero di settembre del 1935 della rivista Pan, Luigi Foscolo Benedetti notò acutamente che «il Carducci riflette nella sua arte matura tutte le maggiori tendenze della Francia postromantica», ed è chiaro che volle riferirsi all’esperienza baudelairiana, nel quadro di un più vasto influsso esercitato su di lui dalla poesia parnassiana e in particolare da Gautier, Leconte de Lisle e Banville.
La conferma di questa tendenza, che il Carducci ha ripetutamente smentito, sempre con poca convinzione però, si trova in uno scritto del Nencioni, che nel Fanfulla della domenica del 1880 rimproverava al poeta maremmano il distacco dalla poesia giambica o d’invettiva politica, in omaggio a quello che già poteva chiamarsi un parnassianismo carducciano: «Nè io so lodare in lui quella tendenza che qua e là trasparisce nei suoi versi a fare delle voluttà sensuali e pagane, un ideale di vita. Lasciando andare che questo ideale sarebbe a ogni modo riserbato a ben pochi, dacchè la gran moltitudine delle plebi sofferenti, e i malati ed i vecchi ne sarebbero privi; non piace di udire accenti epicurei dalla stessa bocca che ha cantato così altamente le nobili passioni, i fieri sdegni, la pura natura e i santi entusiasmi. Augurerei di trovar sempre nelle pagine del nostro Carducci quell’alito vasto e umano di giustizia, di libertà e di ideale bellezza, che spira nei drammi dello Schiller e nei poemi dello Shelley». La risposta a questa rampogna sarà il Congedo, la più parnassiana di tutte le poesie del Carducci.
Sarà opportuno comunque risalire alle origini e stabilire il momento in cui i versi di Baudelaire capitarono tra le mani del Carducci: «Ieri ebbi il Baudelaire», scriveva al Chiarini, il 9 aprile 1872: «per non sbagliare, ordinai tutte le opere, comprese anche le traduzioni del Poe. Ho letto pochissimo, ma parmi, a modo suo, artista finissimo e padrone nell’uso de’ suoi strani ghirigori e delle profonde incisioni: è singolare, e a molti punti, bello, proprio bello». Il 1857 è l’anno in cui Carducci compone Le Rime ed escono in Francia I fiori del male, una coincidenza che ancora non può ovviamente avvalorare ipotesi comparative, ma almeno una data occorre ricordare nel corso di questi anni, quella della morte di Augusto Comte, nel 1899, in coincidenza con la pubblicazione carducciana di Rime e ritmi, l’ultima del suo lavoro poetico, e sicuramente quella più vicina all’avventura francese del parnassianesimo. Con la scomparsa di Comte cadeva l’ipotesi del positivismo e la letteratura francese, dopo l’avventura del naturalismo, soprattutto in prosa, ribaltava del tutto l’ipotesi romantica del disvelamento idealistico per rovesciare la condizione dell’io poetante, ormai più fortemente orientato verso il culto della sonorità e della rotondità della parola poetica che non lungo i crinali del contenutismo puro.
Il punto di saldatura che consente oggi, alla luce dei più recenti studi compiuti nei confronti di un possibile incontro fra Carducci e Dino Campana, di accostare queste due dominanti figure, si esprime nel parnassianesimo, il primo dei tre momenti attraverso i quali si è sviluppato il fenomeno del decadentismo: gli altri due infatti, il simbolismo e l’impressionismo, riguardano più da vicino Pascoli e D’Annunzio, quest’ultimo più fortemente orientato verso l’arte impressionista, il terzo e ultimo stadio dell’intero processo. Il parnassianesimo,con le sue stesse derivanze linguistiche e simboliche, non poteva non attrarre un poeta nutritosi alle muse della classicità come Carducci, e infatti la ricchezza tornita della parola carducciana lo evidenzia in modo particolare, laddove la cura sottile e attenta dei suoni riconduce il poeta maremmano verso approdi della lingua poetica fortemente mirati a conseguire quelle armonie sonore che lui stesso cercava e individuava nei “sonanti metalli” del Wagner possente, quello della Cavalcata delle Valchirie per intenderci.
E certo non minor rilievo hanno le carducciane letture, più volte confessate, oltre che di Baudelaire, di Edgar Allan Poe, pur nella tenace smentita carducciana di ogni legame con l’autore dei Fiori del male.Proprio nel l872,1’anno della scoperta di Baudelaire, Carducci compose le Vendette della luna e il richiamo ai Bienfaits de la lune del poeta francese viene spontaneo e naturale, e quel tramite di passaggio e di convalida, che si configura in Dino Campana, si disvela in tutta la sua evidenza.La parentela Carducci/Campana discende dunque per due rami: introspezione baudelairiane, che Carducci smentisce e Campana ammette con entusiasmo, e tendenza comune verso una ispirazione diversa e più sana e più pacata. Le due fonti, quindi, anzichè escludersi a vicenda, paiono integrarsi: d’altronde una sottesa sensibilità di errante perseguitato, quale fu quella di Campana, non doveva necessariamente precludergli il cammino verso una forma classica della vita e dell’arte; verso l’idea di una felicità, com’egli diceva “mediterranea”, idea che sembrava respirata nelle città tirrene del nostro Trecento: «Il secondo stadio dello spirito è lo stadio mediterraneo.
Deriva direttamente dal naturalismo. La vita qual’è la conosciamo: ora facciamo il sogno della vita in blocco, anche un fanciullo è uno stadio ulteriore della vita in blocco, ma è una forma dello spirito sempre speculativa, sempre inibitoria in cui il mondo è volontà e rappresentazione: ancora, volontà e rappresentazione che del mondo fa la base di un cono luminoso, i cui raggi si concentrano in un punto dell’infinito, nel Nulla, in Dio. Sì: scorrere sopra la vita questo sarebbe necessario, questa è l’unica arte possibile». Alcuni critici frettolosi hanno tentato spesso di fondere, o meglio di confondere, il Campana “mediterraneo” e popolaresco, tramandatoci dal Binazzi, con quello “classico” di De Robertis; i più seri e consapevoli, invece, si suddivisero in due schiere. Da una parte, quelli che videro in Campana il poeta “visivo”, sulla falsariga di una certa nostra tradizione; dall’altra quelli che, pur tra qualche contrasto, puntarono sulla “nozione antitetica” di veggente o visionario, in stretto rapporto coi “maudits” francesi del secondo Ottocento, o addirittura, secondo un’ipotesi fascinosa di Angelo Romanò, con la “scapigliatura”.
Ripetutamente, e con notevole lucidità, Gianfranco Contini ha sostenuto la prima tesi, correggendo la confusione tra frammentarismo e visività e affermando decisamente che «Campana non è un veggente o un visionario: è un visivo, che è quasi la cosa inversa... Si dice: visivo, e s’intende... un temperamento così esclusivo da assorbire e fondere in quella categoria di impressioni ogni altra ...». «Non è colpa di nessuno», prosegue il Contini, «se questo presunto poeta messianico è l’ultimo della tradizione carducciana, cioè di una tradizione sommaria e nei momenti migliori barbaricamente sontuosa. (Pensiamo al Carducci pànico di Cecchi e di Borghese, non al Carducci dei vociani stretti, a quello di Serra e di Slataper).
C’è tanto Carducci nell’apertura di distico, quanto D’Annunzio in quel varcare di fonti, in quegli albori e quelle vive fonti».Quest’ultimo giudizio critico è molto più vicino di quanto non sembri a quello di De Robertis, che tra i primi percepì le «nuove armonie, una freschezza impetuosa di accenti», un rapimento e una certa vicinanza, insomma, alla verginità del dettato poetico carducciano («Leggevo qua e là; Carducci mi piace molto»: «Cercavo armonizzare dei colori, delle forme.
Nel paesaggio italiano collocavo dei ricordi», scriveva il poeta a proposito di Arabesco-Olimpia, un brano che merita la massima attenzione: «Se esiste la capanna di Cèzanne pensai quando sui prati verdi tra i tronchi d’alberi una baccante rossa mi chiese un fiore quando a Berna guerriera munita di statue di legno sul ponte che passa l’Aar una signora si innamorò dei miei occhi di fauno e a Berna colando l’acqua, lucente come un secondo cadavere, il bello straniero non potè più a lungo sostare? Fanfara inclinata, rabesco allo spazio dei prati, Berna».
E ancora: «Come la quercia all’ombra i suoi ciuffi per conche verdi l’acqua colando dei fiori bianchi e rossi sul muro sono spuntati come tra i fiori del cardo i vostri occhi blu fiordaliso in un tramonto di torricelle rosse perchè io pensavo ad Olimpia che aveva i denti di perla la prima volta che la vidi nella prima gioventù».In quest’ultima “trasposizione”, un po’ parnassiana e molto simbolista, c’è già il tentativo di immettere “il senso dei colori”, che prima non c’era, nella poesia italiana; ma anche la tendenza a creare “una poesia europea musicale colorita”: il che avvalora la tesi di una certa fusione di elementi originari parnassiani e baudelairiani, con atteggiamenti e intonazioni tradizionali, tipici del sentimento carducciano.
Le vele le vele le veleChe schioccano e frustano al ventoChe gonfia di vane sequeleLe vele le vele le veleChe tesson e tesson: lamentoVolubil che l’onda che ammorzaNe l’onda volubile smorzaNe l’ultimo schianto crudeleLe vele le vele le vele
Questo frammento, pur nelle strettoie di una insistenza linguistica, fa pensare a certe movenze del giovane Carducci:
Passa la nave mia, sola, tra il pianto Degli alcion, per l’acqua procellosa;E la involge e la batte e mai non posa,De l’onde il tuon, de i folgori lo schianto.
Spesso in Carducci e in Campana c’è una crudeltà d’immagini nel trasfigurare liricamente i propri dolori e nello scandaglio della propria anima, che riporta questi due poeti alla comune sorgente dei fiori malvagi e maliosi di Baudelaire. In Campana, la parola sembra sfaldarsi in un’ansia maggiore:
Umanità fervente sullo sproneChe discende sul mareUmanità che brilla e si consigliaSotto l’azzurro dell’infinità:Passano l’ore, vengono i prodigiSuoi giù dal cieloE tace e ondeggia l’umana famiglia.
In Carducci il ripensamento alfieriano e foscoliano si stempera nell’immagine simbolica:
Tirreno, anche il mio petto è un mar profondoE di tempeste, o grande, a te non cede:L’anima mia rugge ne’ flutti, e a tondoSuoi brevi lidi e il picciol cielo fiede.
In Baudelaire, è la coscienza stessa della schiavitù carnale ad assumere toni e fattezze di simbolo:
Homme libre, toujours tu chèriras la mer!La mer est ton miroir; tu contemples ton âmeDans le dèroulement infini de sa lame,Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer.
A volte, la parentela tra Carducci e Campana è rintracciabile anche in certe movenze del linguaggio e del ritmo, oltre che in certe repentine crisi di contenuto; la celebre confessione programmatica dell’Idillio Maremmano:
Or freddo assiduo, del pensiero il tarlo Mi trafora il cervello, ond’io dolenteMisere cose scrivo e tristi parlo.Guasti i muscoli e il cuor da la rea mente,Corrose l’ossa dal malor civile,Mi divincolo in van rabbiosamente.
possiede innegabili affinità di forma e di sostanza con un frammento del Quaderno, anche se il dilagare delle immagini visive produce nel verso di Campana effetti allucinanti, che è raro trovare in Carducci:
O poesia tu più non tornerai Eleganza eleganzaArco teso della bellezza.La carne è stanca, s’annebbia il cervello, si stancaPalme grigie senza odore si allunganoDavanti al deserto del mareNon campane, fischi che lacerano l’azzurroNon canti, gridaE su questa aridità furenteLa forma leggera dai sacri occhi bruniOndulante portando il tabernacolo del seno:I cubi degli alti palazzi torreggianoMinacciando enormi sull’erta ripidaNell’ardore catastrofico
Ancora oggi, uno dei problemi fondamentali della critica campaniana resta quello della formazione culturale e dei conseguenti influssi che il poeta subì dagli ambienti letterari italiani e stranieri, sia del secondo Ottocento, che contemporanei; soprattutto perchè in tal modo soltanto si potrà evitare che la figura di Campana resti isolata nello svolgimento della nostra letteratura del primo Novecento. In altri termini, è utile considerare il “fenomeno” Campana sul piano del processo evolutivo delle nostre lettere: in un attento studio sul poeta di Marradi, Mario Costanzo, impegnato in quest’opera di revisione e di inserimento critico, scrive: « È evidente l’errore in cui sono incorsi alcuni critici, quando hanno creduto di poter scoprire nella “follia” o nel cosiddetto “ulissismo” di Campana la ragione degli aspetti più oscuri e gelosi della sua poesia.
L’errore, voglio dire, di aver cercato nella sua sensibilità esasperata non solo un’occasione, un “ incitamentum”, per giungere allo stato di grazia, alla “misteriosa alchimìa del verbo”, ma anche la giustificazione di ogni difetto e cedimento o grossezza di espressione, che diano luogo nella sua scrittura ad ambiguità e incertezze, là dove non sia stata conseguita la “voluta e tentata chiarezza”, la “felicità apollinea” e la “serenità contemplativa”. L’errore di aver individuato i punti morti della sua lirica in quei brani in cui riesca più difficile rintracciare tutti gli “indispensabili” “legami e trapassi”, e i “nessi logici”, e la coerenza e la coesione “indispensabili”; mettendo di preferenza l’accento ora sulla “primitività scabra e solenne” di Campana, ora sul suo carattere carducciano e toscano, “italico” e “mediterraneo”. L’errore, infine, di aver giudicato elemento essenziale della sua personalità poetica la facoltà “visiva”: cioè la facoltà che taluno ha ritenuto “dominante” in quasi tutta la moderna prosa lirica italiana, e in tutta la letteratura capitolistica, “esclusiva della modernità”.
Si può esser d’accordo col Costanzo solo su alcune facili e ormai scontate “rivendicazioni” critiche: la confusione, ad esempio, tra “visivo” e “visionario”, o la “sensibilità esasperata” come giustificazione di alcuni atteggiamenti tipici di Campana: ma se si vuol proporre un’indagine sul camino poetico e sulla formazione culturale del poeta, è necessario ripercorrere i due filoni di un Campana “poeta mediterraneo” e popolaresco o arcaico e di un Campana classico e “aristocratico”, quale lo vide il Contini; senza alcuna intenzione, beninteso, di conciliare o addirittura confondere questi due momenti di educazione letteraria. Del resto, è lo stesso Costanzo ad ammettere in molte pagine campaniane modi letterari tra carducciani e dannunziani e a considerare «il suo stesso carduccianesimo, come un semplice punto di partenza, da cui egli muove, in realtà, per giungere a una lirica di tipo “nuovo”, di cui nella sua opera sono innumerevoli presentimenti».
È innegabile che il difetto, in Campana, di uno “scavo autocritico”, di una lucida scelta di volontà di stile, così sensibile in poeti successivi, nota Sergio Solmi, quali Montale e Ungaretti, rende ancor più difficile l’identificazione di parentele, che in poesia sono fascinose e stucchevoli, forse in egual misura. Ma una indagine su quanto di tradizionale ci sia nella poesia di un uomo, che molti hanno tentato di isolare dallo svolgimento stesso della nostra lirica, è alla base di tutto un lavoro critico; per questo, è possibile un accostamento Carducci-Campana, anche oltre i limiti posti dal De Robertis: per le innumeri “aperture” coraggiose, che si trovano nella poesia carducciana, molto più “moderna” di quanto ancora oggi non si creda, e per quei “momenti” così improvvisi e felici di canto a gola spiegata, che sono tra le più valide testimonianze di un volo immaturamente interrotto.